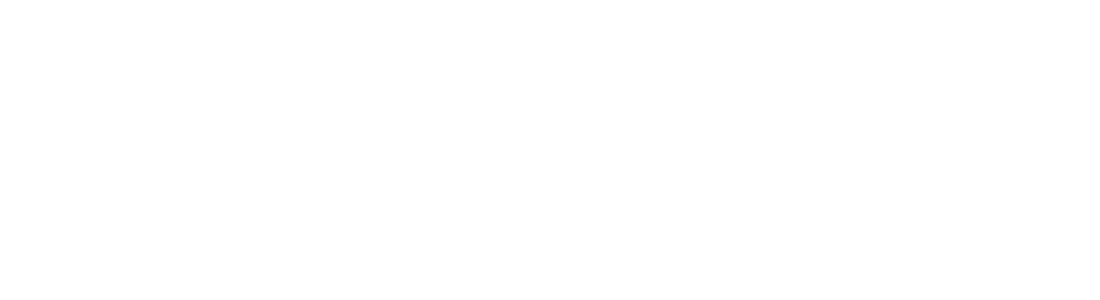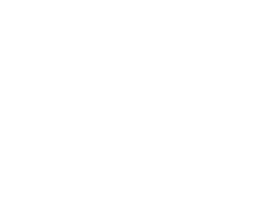Jacopo Martini
La mia strada verso Django
Intervista a Jacopo Martini
di Pierluigi Sassetti
“Vola sentì parlare dei Reinhardt e si aggregò a loro. Si fermò a suonare con loro tutte le sere per tre settimane. Vola non aveva mai suonato un jazz di quel genere prima. Django suonava così veloce, così anticonvenzionale: riusciva a trovare degli accordi che Vola non aveva mai trovato prima. La sua chitarra riusciva a starnutire, ansimare, cantare e piangere, sapeva lamentarsi, esclamare, spiegare, soprattutto spiegare. Il significato della vita diventava immediatamente chiaro per Vola. Era come la religione, o la droga. Illuminazione. Era diventato per lui un bisogno”.
(Mike Zwerin, Musica degenerata)
Chitarra classica
Non ho mai fatto il musicista classico. Ho studiato chitarra classica e non mi sono mai diplomato al conservatorio. Ho fatto un percorso molto veloce con la chitarra classica perché mi ero appassionato molto a questo strumento, al suo suono e fin dall’inizio ho pensato di studiare con chi per me, in quel periodo, rappresentava il migliore di tutti, ovvero Flavio Cucchi. Lui insegnava al conservatorio di Livorno, al Mascagni, e mi ricordo che passai un anno intero a suonare assiduamente perché volevo entrarci a tutti i costi. Trascorsi un anno a studiare come un pazzo per passare l’esame perché sapevo che c’erano circa trentacinque, trentasei candidati e un solo posto disponibile. Incredibilmente quel posto lo presi io, arrivai primo. Così cominciai a studiare con Cucchi e raggiunsi il quinto anno di conservatorio che preparai in un solo anno. Poi, un po’ per instabilità giovanile (già suonavo jazz e mi chiedevo se avrei fatto meglio il chitarrista classico o quello jazz), un po’ perché nel frattempo ero venuto a studiare a Firenze, dove sono stato allievo di Borghese, sentivo che questa faccenda della chitarra classica mi stava pesando, perché avevo la sensazione di averla trascinata per anni senza sapere che farne. A tutto questo si aggiunse il fatto che Borghese mi propose di rivedere i fondamentali della chitarra classica, nonostante suonassi già i pezzi dell’ottavo anno, Villa Lobos e così via. Iniziai così nuovamente da capo, dal tocco appoggiato insomma. Andai avanti per tre anni, finché dopo un po’ dissi “basta”. Ma a me è sempre piaciuta la chitarra classica, e penso che il jazz manouche un po’ le si avvicini, perché ci sono degli aspetti in comune, dal virtuosismo a un linguaggio musicale (più europeo), il suono, che può essere riconducibile alla musica classica. Anche le corde che vengono utilizzate per la chitarra manouche sono molto simili a quelle della chitarra classica, per un suono che potrei definire un po’ argentino. Inoltre, la tecnica del plettro appoggiato e anche il repertorio, tutto il repertorio chitarristico dell’America latina, i valse venezuelani di Lauro, di Barrios. Ci sono davvero tante affinità con il repertorio del valse manouche. Comunque, per me, è stato sicuramente un amore che mi ha permesso di entrare nel mondo della chitarra e di scoprirlo.
Django Reinhardt
Ho ascoltato la prima volta il jazz manouche e non tanto Django Reinhardt. Django per me è un grande jazzista. Oggi viene definito come il capostipite di questo stile musicale, ma in realtà lui voleva fare tutt’altro, non pensava certo che dopo la sua morte potesse nascere questo fenomeno di riproposizione della sua musica. Django era un musicista molto moderno, una novità rispetto a tutto quanto esisteva prima del suo avvento, un po’ alla Pat Metheny, se vogliamo, un chitarrista con uno stile particolare e una sonorità nuova. Purtroppo, secondo me, è rimasto confinato dentro quel mondo; c’è tutto il periodo del “Django elettrico” degli anni ‘40 fino alla fine della sua vita che è molto particolare. Lui, poco prima di morire, si era già ritirato, se ne era tornato a Samois; l’esperienza dell’America non fu molto felice, forse perché non era abituato a quei ritmi lavorativi. C’è un aneddoto su Duke Ellington – che per certi aspetti si dice fosse stato un musicista molto severo – dove si racconta che Django arrivò al concerto in ritardo, senza chitarra, perché pensava che tutti i liutai importanti gli regalassero una chitarra al suo arrivo. Questo ovviamente non accadde. Ma tornando al suo stile, alla sua composizione, il suono che aveva in quel periodo era incredibile, non era bebop, anche se ricorda quelle atmosfere; in certi casi il suono è addirittura distorto, non per volontà ma perché magari suonando molto forte con la mano destra faceva andare in saturazione quegli amplificatori. Si può dire paradossalmente che abbia influenzato più i chitarristi rock che i chitarristi jazz, perché i chitarristi jazz elettrici hanno iniziato a seguire la linea sassofonistica per una dissociazione vera da quello che era lo strumento della chitarra. Chuck Wayne, Jim Raney, ad esempio, se ascolti le loro linee, l’uso che facevano dello sweep, del legato, diventano fluide proprio per imitare il suono del sassofono. Invece Django suonava come un chitarrista. Un chitarrista che adoro è Jim Hall. Detto da lui, ma comunque si sente chiaramente che c’è Django nel suo modo di suonare, si sente che è stato influenzato tantissimo da Django Reinhardt e l’ha sempre detto. Jim Hall, anche quando accompagna – se ascolti i dischi che ha fatto con Bill Evans, che sono bellissimi – ha una ritmica in quattro che non è la pompe manouche, e usa una certa alternanza di bassi; poi quando fa i soli, si sente Django Reinhardt nelle sue note.
La chitarra
In casa mia la musica, specialmente per mio padre, era all’ordine del giorno. Questo perché mio padre era un pittore, non un musicista, anche se da ragazzo aveva studiato e anche fatto qualcosa nel mondo della lirica, era un baritono. Ovviamente amava soprattutto la musica lirica e la musica sinfonica in generale, non tanto il jazz. Mi ricordo di quando ero piccolo, di tutti quei dischi, di uno stereo pazzesco e le feste a casa dove invitava certi pianisti a suonare. Poi le cene e, dopo, il canto fino a fine serata. Una cosa che a dire il vero mi dava anche fastidio, perché da bambino la vedevo come una mancanza di attenzione nei miei confronti. Tutto questo è stato parte integrante della mia infanzia e della mia adolescenza. Con i miei genitori poi andavamo sempre a teatro e mi ricordo di una volta in particolare che fui colpito dall’Orfeo di Monteverdi. Avrò avuto circa dieci anni e il giorno dopo cantai un’aria di quell’opera in modo perfetto, e i miei genitori si stupirono molto di questa cosa. Sulla scia di questo evento mi feci poi regalare un mandolino, e non saprei dirti come mai desiderassi quello strumento; forse, probabilmente, per riprendere quelle linee melodiche che avevo ascoltato, una cosa che iniziai a fare completamente a caso, come fanno i bambini quando giocano con uno strumento.
Successivamente, un anno dopo, siccome ero un grande appassionato di Sherlock Holmes, e Sherlock Holmes durante le pause tra un caso e l’altro suonava il violino, mi feci regalare anche un violino. Studiai il violino per un po’, perché una mia zia paterna mi pagò un corso in una scuola, un corso che portai avanti per circa un anno. Ma il violino è uno strumento abbastanza ostico. All’inizio, secondo me, ci vuole la frusta e in casa mia non c’era la volontà, giustamente, di obbligarmi a studiare controvoglia. I miei mi lasciavano molto libero e quindi fu naturale abbandonarlo.
La chitarra invece l’ho presa molto tempo dopo, verso i tredici anni, forse quattordici, già grande e maturo per scegliere, e capitò per caso perché chiesi a un mio amico di insegnarmi qualche accordo. Questo mio amico suonava le canzoni di Battisti e De Gregori, e ciò che faceva mi incuriosiva, ma soprattutto mi attirava. Gli chiesi così di mostrarmi come si fa a suonare quegli accordi, e lui mi insegnò due o tre posizioni e col tempo si rese conto che la cosa mi prendeva, che volevo imparare sempre di più. Quindi, dopo un po’ di tempo, mi mandò a lezione da un suo amico molto bravo che faceva fingerstyle e altre cose, e con questo signore cominciai a studiare seriamente, a fare anche brani classici, improvvisazione, perché era un’insegnante decisamente poliedrico.
A sedici anni, come tutti, ho avuto la passione per il rock, erano gli anni novanta, imperversava l’heavy metal, e ci sono cascato anch’io, per poco, però … e quindi mi comprai il mio Marshall, la mia chitarra elettrica, avevo il gruppo del liceo e insomma ero pienamente nella regola, nella norma.
Infine andai a lezione da un chitarrista che mi ha trasmesso tanto, un chitarrista jazz, un grandissimo didatta, che amava molto la chitarra classica: Gianni Zei. Mi ricordo che andavo a lezione da lui e mi faceva ascoltare i pezzi di Ralph Towner o di chitarra brasiliana come Irio de Paula, e mi prese la voglia di studiare quel tipo di musica.
Il Jazz
Il jazz è arrivato un po’ da solo, per curiosità. Avevo un bis-zio che amava molto Thelonious Monk e mi regalò una cassetta di Monk che mi piaceva, l’ascoltavo, anche se non capivo veramente nulla di quello che stava succedendo, ma l’atmosfera e il suono mi prendevano. Conobbi poi un sassofonista qui a Firenze, che suonava jazz, e io mi trovavo in una fase statica in cui suonavo prevalentemente musica classica e rock. Con lui iniziai a suonare i primi standard, a leggere le sigle degli accordi, e mi ricordo che mi perdevo sempre sulle strutture e lui si incazzava. Dopo il conservatorio cominciai a suonare prevalentemente jazz nei gruppi di Firenze, le jam session al Jazz Club e iniziai a frequentare pochi musicisti, pochi ma buoni, nel senso che come tutti mi sono avvicinato a qualcuno di affidabile per un considerevole lasso di tempo, perchè ad un dato momento si sente la necessità di un punto di riferimento, una collaborazione, e nel mio caso fu Emanuele Parrini, un violinista. Assieme abbiamo fatto molte cose, cose importanti tra cui il mio primo disco come musicista. Presi parte all’incisione di Rotella variation, dove incredibilmente ho avuto l’onore di suonare con dei musicisti che rappresentano la storia del jazz italiano, come Enrico Rava Gianluigi Trovesi e Tiziana Ghiglioni. Rotella variation era un disco incentrato sul concetto artistico di Mimmo Rotella, e quindi questi strappi sonori, che Rotella aveva composto intorno agli anni cinquanta-settanta, dei poemi fonetici, che noi arrangiammo e musicammo; un disco molto di confine, di musica improvvisata, interessante.
Il Manouche
Insomma, non ero ancora collocato in uno stile, mi piaceva un po’ tutto, dal bebop, Pat Martino a livello chitarristico, ad esempio; mi capitava di suonare free o altre cose come il funky, fino al momento in cui conobbi la musica di Django. È accaduto intorno al 1999, perché frequentavo un negozio di dischi in Piazza Duomo a Firenze dove conoscevo Lucio Apicella, uno che di ragazzi, da un punto di vista musicale, ne ha drogati veramente tanti. Io andavo sempre lì a comprare i dischi, il sabato, con la paghetta, e ne compravo parecchi. Quando poi non sapevo cosa scegliere, mi facevo consigliare da Lucio. Ad esempio l’altro giorno, mi è capitato di ascoltare un disco di Oliver Nelson e Eric Dolphy, Straight Ahead, non pensavo neppure di averlo e l’ho ascoltato per una settimana di fila, è meraviglioso, e questo è sicuramente un disco che ho comprato da Lucio. Comunque, un giorno, ero indeciso su cosa acquistare e lui mi chiese se conoscessi Django Reinhardt. Certo che lo conoscevo, l’avevo sentito nominare, però non ne ero mai stato incuriosito, e Lucio mi consigliò Souvenir. A essere sincero, al primo ascolto non mi entusiasmò più di tanto, perché ero abituato ad ascoltare musicisti come Ralph Towner, Pat Metheny, Keith Jarrett, e con Django mi ritrovai davanti a questa cosa strana, un po’ frusciante, il violino. Pian piano iniziai ad entrarci dentro anche perché Lucio, successivamente mi propose, dopo aver saputo che ero un chitarrista, di entrare a far parte del suo gruppo, dove anche lui suonava la chitarra ritmica e il suo gruppo suonava musica di Django. Lucio voleva organizzare un quintetto, in stile Hot club, e tra le altre cose trovò un nome decisamente originale per quel gruppo, Hot Club de Florence. Avevano bisogno di una chitarra solista, in un periodo dove non c’era nessuno che suonasse quella musica, e neppure loro erano molto esperti di quel genere, perché tutti provenivano da altri ambienti, in particolar modo dal jazz. Quello più ferrato in materia era Lucio. Mi avvicinai a quella musica con il mio modo di suonare, con la chitarra elettrica, da chitarrista jazz con la sua archtop.
E poi che cosa è accaduto? A un certo punto ho sentito il bisogno di capire, perché quella musica mi stava prendendo e perché sentivo di essere vicino a quello che stavo cercando. Feci così il mio primo viaggio a Samois, nel 2000 dove in quel particolare anno, suonava per la prima volta un chitarrista italiano, Maurizio Geri. A Samois vedevo questi chitarristi che suonavano tra di loro, che jammavano, con questa impostazione particolare della mano destra, e mi impressionarono, mi resi conto che c’era da lavorare per ottenere quel suono. Dieci anni fa non c’era You Tube, non c’era nulla per vedere e capire. Avevo fatto esperienza ascoltando i primi dischi di Rosenberg, di Debarre e stavo ad ascoltare queste linee melodiche dalla mattina alla sera, le trascrivevo, le rifacevo, ma mi rendevo conto che il suono non era quello. Suonavo con la pennata alternata, naturalmente, e per questo motivo il suono non tornava, non era lo stesso. Da solo, a orecchio, arrivai a capire come stavano le cose anche se non ne ero sicurissimo, e per questo motivo, quando finalmente mi trovai a Samois ne ebbi finalmente la riprova. Tornai da quel viaggio con una voglia allucinante di suonare quella musica e mi ci buttai a capofitto smettendo di suonare tutto il resto. Comprai la mia prima chitarra manouche, una Dell’Arte e pian piano sentivo di avvicinarmi a quel suono. Poi il gruppo di Lucio si sciolse e così, assieme a lui, mettemmo su un trio con un bassista per continuare a suonare la musica di Django. Lucio mi dette veramente una grande mano perché in realtà, pur non sapendo niente di musica, mi invogliava a studiare un certo tipo di repertorio, mi dava i brani da imparare e il lavoro che iniziai a fare fu nuovo, mai fatto prima, ovvero quello di sprofondare letteralmente nella trascrizione. Un lavoro faticoso, lento, e anche estremamente complesso perché stavo trascrivendo Django, un chitarrista geniale, imprevedibile, unico. Tu ascolti Django e, vuoi per la registrazione vecchia, vuoi per la sua imprevedibilità, non capisci mai chiaramente cosa sta suonando, cosa stia facendo. È difficile Django, un po’ come Wes Montgomery, questi musicisti sono al di sopra di ogni cosa, inarrivabili.
Pian piano iniziai a ingranare, fino al giorno in cui altri chitarristi cominciarono a contattarmi per venire a lezione da me. Ero diventato in poco tempo una specie di punto di riferimento, perché in giro c’erano pochi chitarristi che suonavano musica manouche, e anche perché stava nascendo una certa moda dopo il film di Woody Allen. Ci fu un periodo che arrivava gente a lezione da tutta Italia, dalla Puglia, dalla Sicilia, non capivo. Tutto era comunque causato dal fatto che avevo messo dei miei video su You Tube.
I Nuvoli
Poi è arrivato il primo disco, i Nuvoli. Per questo disco chiamai a suonare Antonello Salis. Lo considero un disco interessante perché chiaramente non c’entra niente con il jazz manouche, non è un lavoro in stile, e ho tentato di racchiuderci tutto il mio percorso da quando suonavo la chitarra classica. Penso sia un disco particolare, direi di confine, non ben collocato, perché non è marcatamente jazz manouche. A livello di vendite e di richieste di lavoro non ha prodotto molto, ma sono arrivate inaspettatamente grandi critiche, anche da parte di riviste specializzate, o fatte da importanti addetti del settore come Alain Antonietto che mi definì “il più originale rievocatore della chitarra manouche apparso negli ultimi anni”. E Salis apportò tantissimo al progetto, il suo modo di suonare caratteristico e personale è inscritto in questo lavoro.
Il virtuosismo
Ho sempre cercato di fare del mio, senza legarmi al virtuosismo fine a se stesso, preferendo concentrarmi sulla scelta del repertorio, come fanno tanti. Ma oggi non funziona così: l’ascoltatore medio, in un genere di nicchia come questo, vuole ascoltare quella roba che tentano di fare tutti, ovvero il grande virtuoso che si cimenta su Minor Swing e fa le frasi che fanno tutti.
Nella musica manouche, secondo me, non è obbligatorio essere dei virtuosi, il virtuosismo purtroppo c’è, ma poi è anche necessario chiedersi che cosa sia questo virtuosismo. Dal mio punto di vista non vuol dire essere veloci, ma è un’altra faccenda, anche se spesso le due cose vengono associate. Spesso pensiamo che se un musicista suona in modo veloce allora si tratti di un musicista virtuoso, ma se prendiamo il dizionario della lingua italiana e andiamo a cercare il significato del termine “virtuoso” troviamo un’altra cosa.
Django suonava pezzi veloci, tecnicamente sbalorditivi, ma non era solo questo, anzi, la sua capacità era quella di stupire l’ascoltatore, perché faceva delle cose molto melodiche, frasi strappacuore e poi a un certo punto inseriva delle cose velocissime, ma lo faceva ogni tanto. Purtroppo molti musicisti hanno preso quelle cinque, dieci cose caratteristiche del suo stile, come le scale cromatiche, l’uso degli accordi diminuiti, e le hanno esasperate. Per questo motivo capita fin troppo spesso di ascoltare questi chitarristi bravissimi che poi con il tempo ti rendi conto che le loro improvvisazioni sono tutte uguali. Senti un brano ed è come se tu li avessi sentiti tutti, gli assoli sono sempre gli stessi e ti dirò di più: frequentando l’ambiente manouche, capisci come molti di quei chitarristi siano paragonabili a dei chitarristi classici perché non improvvisano più, ma semplicemente rifanno sempre i soliti assoli di concerto in concerto, assoli studiati, perfetti, nota per nota. Molti suonano anche i soli di Django, perfettamente uguali.
Arma a doppio taglio.
È un’arma a doppio taglio questa musica, e qui arriviamo al nocciolo della questione. È un’arma a doppio taglio perché affascina, è un genere bellissimo, una sintesi tra due mondi, tra l’Europa e il jazz più americano … poi c’è anche la cultura della musica zingara. Però a un certo punto diventa una gabbia e difatti l’ho personalmente sperimentato: dopo un periodo di grande amore – in cui ho smesso di fare tutto e mi sono buttato anima e corpo nello studio di questo stile – c’è stato una specie di rigetto, una voglia di tornare alle mie origini. Sono sempre stato abituato a suonare quello che mi piace, non mi vergogno a dirlo, anche in modo nevrotico se vuoi, perché è anche la mia indole, quella di cercare continuamente, senza volermi considerare un musicista fatto. Ancora oggi sono lì che cerco, che scopro, perché mi piace entrare dentro i vari stili musicali e prendere cose, ed è il bello che mi permette di ritrovare le similitudini tra le cose. Molte volte studio Villa Lobos e ci ritrovo qualcosa di Django, ma anche un repertorio che non c’entra niente con la chitarra, che ti porta via dal mondo della chitarra.
La tecnica manouche
Il problema del jazz manouche è questa tecnica così particolare che poi, se tu la studi come ho fatto, ovvero in modo costante, tralasciando tutto il resto, alla fine finisce che suoni solo in quel modo. Quindi inizi a suonare con questo staccato potente, con questo fraseggio molto dritto. Qualche anno fa ti avrei detto che vale la pena studiare in modo approfondito questa tecnica, adesso ho dei dubbi. Dal mio punto di vista vale la pena imparare tutte le tecniche della chitarra, ma è anche vero il contrario, ovvero che c’è gente cui non importa niente di tutta la tecnica e preferisce suonare come gli pare e come gli viene, suonando in egual modo benissimo.
Vale la pena imparare questa tecnica? Si, perché no. Ma ci sono chitarristi molto bravi, famosi, che suonano jazz manouche e che se ne sono fregati. Certo, mi ritengo penalizzato come tutti i non-zingari che non sono vissuti in quel contesto lì, che non hanno respirato quella musica nel contesto familiare dove c’è sempre qualcuno che suona, dove nasci e cresci vedendo come stanno le mani, questa mano destra che pesa tantissimo. Il chitarrista che proviene da questa cultura zingara, pur non essendo un chitarrista di professione, se gli dai la possibilità di suonare una qualsiasi chitarra, riuscirà a far suonare un accordo con il triplo del mio suono, perché non basta essere tecnici. Come si dice in gergo, la “castagna” la “botta”.
Imparare la chitarra manouche
Per un certo periodo ho suonato con un chitarrista che si chiama Matcho Winterstein. Mi sono buttato a capofitto in quella collaborazione, volevo suonare sempre con lui, capire, rubargli segreti, e non sono delle vere e proprie lezioni, perché non si può parlare di lezioni. Loro non sanno insegnare, tante volte non conoscono neppure gli accordi che stanno facendo, in che tonalità stanno suonando. Non tutti, certamente, comunque tanti sono così, l’apprendimento della musica è tutto visivo, orale, non hanno spartiti. Ti dicono: “Facciamo questo pezzo e gli accordi sono questi”, poi ti invitano a improvvisare, come fanno loro. C’è da dire che loro iniziano a suonare dedicandosi esclusivamente all’accompagnamento. Accompagnano, accompagnano e difatti hanno una ritmica pazzesca. Poi, in un secondo tempo, solo quando sono in grado di fare bella figura si cimentano anche nell’improvvisazione, ma solo se lo sanno fare bene. La loro cultura è questa, chi si avvicina a questa musica accompagna, con umiltà, servizievole, non si espone mai se non è preparato. Non sentirai mai un manouche che fa un solo sgangherato, che non gli riesce, tanto per fare e provare. Finché non suona veramente, – e glielo dicono gli altri ma lo sa anche da solo – finché non sa di poter fare una bella figura, non suonerà mai un solo in pubblico. Si limiterà a fare quello che sa fare veramente bene. Non accade come da queste parti che uno si butta e inizia a fare un solo con la scala pentatonica. Stai scherzando! Ho avuto il piacere di suonare con questi musicisti, anche con Angelo Debarre, che è uno dei miei preferiti. Sono soddisfazioni.
Adesso che cosa sta succedendo in Francia?
Adesso in Francia c’è un’evoluzione di questa musica. Come in tutte le cose c’è un’evoluzione, e da qualche anno a questa parte sta venendo fuori, si fa sentire. Che cos’è questa evoluzione? Parte tutto dal fatto che Bireli Lagrene ha sicuramente apportato qualcosa di nuovo a questa musica se non altro perché è stato uno dei primi a infilare all’interno di questo contenitore, contenitore manouche, un linguaggio più jazzistico. Tutto questo perché lui ha sempre suonato questa musica fin da bambino, poi si è staccato per fare altro. Ha suonato con Pastorius, ha suonato di tutto, dalla fusion al rock, dal bebop, allo swing al jazz, ha realizzato dischi dove canta, tra le altre cose benissimo, suona il basso elettrico benissimo, un talento incredibile insomma.
Inoltre, secondo me, si tratta di un discorso meramente commerciale: la Dreyfus, la sua etichetta, intorno alla fine degli anni novanta lo ha come invitato a rimettersi a suonare manouche per aver annusato il fatto che la musica di Django stava tornando di moda. Hanno realizzato una serie di dischi, il Gypsy Project che, dal mio punto di vista, è un pacchetto abbastanza commerciale. Bireli ha perfezionato quella musica, l’ha studiata e l’ha in un certo senso cambiata, perché rispetto ai dischi precedenti, ai suoi primi dischi, ha un suono diverso. È stato intelligente perché ha suonato come pareva a lui, infilandoci dentro ciò che gli piaceva e voleva, le sue influenze. E poi è arrivata la cosiddetta “botta”! In Live in Vienna, quel live dove invita tutti quei chitarristi manouche più famosi e li sommerge letteralmente, tutti. In quel video è veramente Dio o quantomeno il Papa, perché Dio è Django.
Dopo tutto questo che cosa è accaduto? Tutti i giovani chitarristi francesi non manouche, una generazione nuova di ragazzi agguerriti, studiosi, e preparati rispetto ai classici chitarristi manouche, si son messi a suonare questo linguaggio nuovo realizzato da Bireli, e nel frattempo questa musica è diventata fortemente di moda; una musica che è emersa prevalentemente in Francia, a Parigi, tra jam session nei locali e dischi nuovi, un grandissimo fermento. Ma questa nuova generazione ha attinto non tanto dalla vecchia scuola del manouche, degli zingari, della tradizione, ma da questo nuovo suono di Bireli. E da qui sono nati quelli che sono i migliori musicisti manouche del mondo. A giugno di quest’anno ho avuto l’onore di partecipare come insegnante e performer al Django in June, un festival incentrato sulla didattica che si tiene tutti gli anni nel Massachusetts. Lì ho conosciuto questi ragazzi suonandoci insieme in concerto e in jam, ed è stata un’esperienza fantastica. Adrien Moignard, Benoit Convert, ad esempio, sono ragazzi giovanissimi, hanno un’età imbarazzante, venticinque anni, e suonano in un modo mostruoso, perché hanno un suono straordinario e al tempo stesso trascendono tutto. Senti Pat Metheny in quel suono, sono andati anche oltre rispetto a Bireli, più avanti ancora. L’ultimo disco di Adrien Moignard è semplicemente pazzesco, anche perché non c’è più neppure questo ruolo della chitarra ritmica incessante che limita tantissimo, se vogliamo. Ha realizzato un disco con un cajòn, basso, due chitarre, che si intrecciano in modo particolare, quasi some se fossero la mano sinistra e la mano destra del pianista. Quindi non c’è più questa pompe incessante. È un disco di musica moderna, di jazz moderno in cui del manouche è rimasto praticamente soltanto il suono delle chitarre.
Il limite di questa cosa, di questo nuovo fenomeno musicale, come sempre accade quando c’è una forte caratterizzazione e un nuovo linguaggio che emerge, è che se vai adesso a Parigi, dal ragazzetto di quindici anni a quello di trenta suonano tutti in questo modo. Tutti uguali. Vai alle jam, e vedi queste schiere di pischelli che addirittura si vestono tutti nello stesso modo, con un look da rock star, con la camicia a quadri, i Ray Ban, il cappellino. Le chitarre sono tutte le stesse, le Olivier Marin, che hanno quel suono un po’ nasale, caratterizzante. E suonano tutti in quel modo, con tante sostituzioni di accordi, tante legature, un po’ come suona anche Michael Gimenez, un amico e collega con il quale collaboro da diverso tempo. A Parigi, ce ne sono tanti adesso di musicisti che suonano in questo modo, si dice: “Suoni alla parigina!”, mentre attualmente lo zingaro è visto come una specie di bifolco. Difatti c’è in quell’ambiente, avendo suonato con entrambi, una cosa che a tratti si potrebbe definire come una specie di rivalità. Sono due ambienti distinti, è incredibile, e a Parigi funziona così, per ambienti chiusi, un po’ settari, e anche all’interno di un solo genere si creano i sottogeneri. Pazzesco!
Harleysti
Anche il jazz manouche rischia di diventare un fenomeno da cover band. In Italia stanno accadendo delle cose molto simili ai classici raduni di auto e moto d’epoca, ovvero eventi musicali che vengono organizzati un po’ da tutte le parti. E non sono dei festival come a Samois, ma dei veri e propri raduni. Alle volte, e lo dico con tutto il rispetto per chi lavora per organizzare questi eventi, queste realtà hanno un sapore che a me personalmente ricorda tantissimo i circoli degli harleysti, o quelli che vanno a fare le gite con la Fiat 500 o con le auto d’epoca.
La curiosità
Un consiglio a chi inizia a suonare questo genere di musica o la musica in generale, è per prima cosa quello di essere curiosi. La curiosità è un motore fondamentale per chi vuol suonare: essere curiosi e non dare mai niente per scontato. Quindi, se devo suonare un brano, me lo studio perfettamente, seguendo il giro degli accordi, andando a ricercare, se voglio, le varie versioni fatte da altri musicisti, e anche la versione originale ovviamente, perché spesso viene lasciato molto al caso. Fin troppi musicisti leggono gli accordi su un Real Book, senza chiedersi perché siano stati utilizzati quegli accordi, le sostituzioni, dando per scontato che quegli accordi siano quelli buoni, senza farsi delle domande. Accade spesso.
Leggerezza e distacco
Bisognerebbe riuscire, allo stesso tempo, ad avere una leggerezza che è difficile da ottenere, un distacco salutare da quello che si fa. Mi viene mente una citazione di Roberto Assagioli, che è il fondatore della psicosintesi, che dice pressappoco così: “Noi siamo dominati da ciò in cui ci identifichiamo e dominiamo ciò in cui non ci identifichiamo”. Se finisco per essere troppo dentro al mio ruolo di musicista e mi costringo a viverci senza più uscirci, non sarò mai capace di mai avere una esecuzione distaccata perché ci son dentro fino al collo, mi faccio un sacco di problemi, e nella musica è così.
Tanti musicisti hanno altri interessi, Django aveva il biliardo e la pesca. Ho suonato un paio di anni con un grandissimo musicista che faceva un sacco di cose quando non suonava, e io, incuriosito, gli chiedevo come facesse a portare avanti tutte quelle attività. Lui mi rispose che di sola musica si finisce per ammazzarsi. Va benissimo fiondarsi sulla musica, studiare, ma anche sapersi distaccare, trovare qualcos’altro che poi fa bene anche alla musica stessa, gli dà quel giusto distacco, ossigeno. Io, ad esempio faccio arti marziali, scherma giapponese del quattrocento (ride!). Le arti marziali sono come la musica, è arte pure quella.
Le tante cose che servono
La musicalità personale è da scoprire. Non sono d’accordo sul concetto di talento; è vero che c’è gente che ha una marcia in più rispetto ad altri, però il talento vuol dire tante cose. Persone che nascono con l’orecchio assoluto, alle quali però manca tutto il resto, le idee ad esempio. Altre che sono stonate come campane ma hanno idee e una capacità imprenditoriale micidiale. Ci vogliono tante cose per arrivare. Anche l’intelligenza di riuscire a mettere assieme le persone giuste è una cosa importante. Perché è importante suonare con i musicisti giusti, che stanno bene insieme sia a livello musicale che umano, e questa non è mai una faccenda da sottovalutare. Poi, naturalmente, c’è il talento per lo studio. Ci sono musicisti che sono talentuosi al punto che gli riesce tutto facile, e non studiano mai perché non hanno voglia e costanza. Io ho studiato tanto, ma tanto, tanto, tanto, quando ero giovane, agli inizi, quando stavo con la chitarra in mano per circa diciotto ore al giorno. In realtà è stato un periodo in cui non avevo vita sociale, una ragazza, amici. Passavo le giornate in casa e da quando mi alzavo a quando andavo a letto ero insieme alla chitarra. Una specie di poeta legato alla sua scrivania. E al tempo stesso c’ho picchiato la testa molte volte, ho tirato la chitarra nel muro in diverse occasioni. Molte cose mi venivano facili, lo sentivo o me lo dicevano i miei insegnanti, ma ciò non toglie che sulla chitarra mi sono fatto un bel culo!
Adesso studio molto meno, o vado a periodi, ma non più come un tempo in cui andavo alla ricerca di cose che non capivo. Con questo non voglio dire che ho capito tutto, assolutamente, ma magari ascolto un disco e se mi piace un brano lo tiro giù a orecchio, oppure, come sta accadendo adesso mi butto sulla chitarra classica. Forse potrei dire che non mi serve a niente suonare quel brano, ma mi piace farlo e lo faccio.
Studiare non studiando
Ci son tanti modi per studiare. Si può studiare non studiando. Avere un’ora di tempo e mettersi a suonare un pezzo, che magari il giorno dopo non ricordi, però intanto l’hai suonato, hai fatto qualcosa, che è puro piacere. Fare! Lo studio non studio è un concetto un po’ diverso rispetto allo stare dieci ore sulla chitarra a studiare cose sterili. Anche la tecnica. Ha più senso studiare un brano che non riesce, un pezzo difficile che ti impone dei ragionamenti che ancora non possiedi, piuttosto che fare le scale con il metronomo fini a se stesse. Lavorando con un brano fai esperienza del suono di quel pezzo, dell’armonia, dei passaggi che ingrandisci, decontestualizzi, lavori a parte, ma intanto è parte integrante di un brano che è musica. Anche non studiare è un modo per studiare. Ho passato un periodo molto bello della mia vita in cui me la godevo, mi godevo la musica e non avevo sensi di colpa, sentivo di non dover studiare a tutti costi. Dirsi ad esempio che si è dei falliti perché non si studia, perché non si tocca la chitarra. Uno studio distaccato, professionale, meno identificato con lo studio per lo studio. Django, ad esempio, come tanti grandissimi musicisti, aveva un rapporto molto distaccato con il proprio strumento. C’è un aneddoto che racconta di come un giorno Django si sia ritrovato a suonare con una chitarra con tre corde e un dente di pettine al posto del plettro. C’è un tipo di musicista che suonerebbe con tutto, che fa suonare di tutto, dal trapano del dentista alla sua barba. La musica è corpo, voce, canto.
L’Eros
Un altro concetto importante per capire certe verità è quello di sentire, nel senso di percepire cosa sentiamo veramente. Questo significa andare liberamente verso qualcosa che sentiamo attraente, l’eros. L’eros ti avvicina, ti spinge, ti invita. Se non c’è eros è un bel problema, non fai niente. Tanti musicisti suonano senza eros: li vedi, sono lì, sono ossessionati dal diventare perfetti ad ogni costo, cosa che non diventeranno mai e per tale motivo saranno dei frustrati per tutta la vita. Ci sono invece musicisti che quando suonano sbagliano, però lo vedi che godono, che sono vivi, che fanno un errore facendolo diventare una cosa bellissima. Fanno quello che piace veramente, e non a parole. Perché devo costringermi a suonare una cosa che non mi va? Adesso qui rientriamo in un discorso più psicologico ma che è parte integrante della faccenda, perché quando lavori con la musica, quando la insegni, andiamo a toccare delle parti intime che prima o poi vengono fuori. Come fai a scindere? Molte volte, un po’ per educazione e un po’ per tutto il percorso che hai avuto nella vita, hai dei parametri che ti impongono di seguire strade pericolose, incerte. Suoni perché vuoi apparire, scegli un repertorio perché hai la necessità di apparire; oppure suoni dei brani perché te li ha consigliati qualcuno, qualcuno di cui ti fidi. Bisognerebbe capire bene come funzionano queste logiche, che spesso non seguono la via del puro piacere di fare ma perché c’è sempre una storia di limiti personali. Uno ci casca e diviene un frustrato, perché è fuori strada.
Mi riconosco in tanti allievi che prendono vie sbagliate soltanto per apparire o per dare soddisfazione al proprio ego. Lo studiare con foga, con ansia, con la tendenza a voler diventare qualcuno a tutti i costi. Il bello della musica, e c’è tanto di bello nella musica, è quello di capire i tuoi limiti, ma è necessario lavorare sui limiti. Bisogna stare attenti per non rischiare la pazzia. Tutto quello che serve … c’è già! Basta riuscire a farlo emergere!
* * *
Il Centro Sperimentale Pedagogico Tyche ricorda che tutti gli articoli presenti all’interno di questo sito possono essere liberamente consultabili e scaricabili. In caso di utilizzo del nostro materiale sarebbe onesto, nonché eticamente corretto, contattare gli autori e citare la fonte. Il Centro Sperimentale Pedagogico Tyche ringrazia e augura buona lettura.