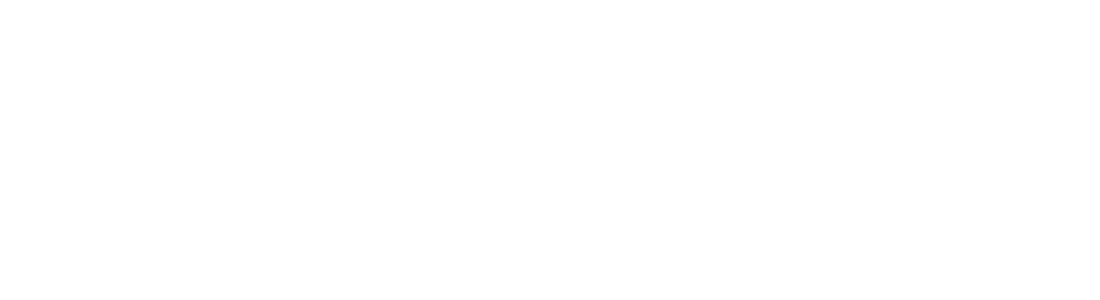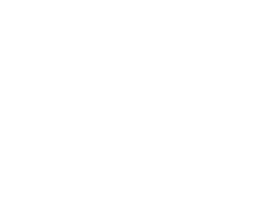Paul Bley o il miracolo della naturalezza – di Arrigo Cappelletti
Intervista ad Arrigo Cappelletti
di Pierluigi Sassetti
Ho qua davanti a me il tuo libro su Paul Bley, La logica del caso, e le pagine di questo libro trasudano in modo autentico della tua amicizia con questo grande musicista. Vorrei avere, se è possibile, qualche dettaglio sul vostro incontro.
Conoscevo molto bene Paul Bley, certamente, ma quello che più conta è che per me come musicista ha rappresentato un faro per moltissimo tempo. Ho ascoltato il suo primo LP nel ‘78 se non ricordo male. Non mi ricordo più il titolo di quell’album, si trattava di un LP in trio, però ho subito colto un’affinità profonda ed è per questo motivo che da quel momento Paul Bley nella mia vita è diventato un punto di riferimento. Naturalmente non l’unico, perché ho vissuto l’influenza di molti altri musicisti come Lenny Tristano, John Lewis, Mc Coy Tyner, Abdullah Ibrahim, Thelonius Monk e soprattutto Bill Evans; però c’è sempre stato un filo rosso a simbolo del mio legame con Paul Bley. Ad un certo punto della mia vita, più o meno verso l’inizio del nuovo secolo, mi sono chiesto se non fosse il caso di chiarire a me stesso che cosa mi aveva attratto così tanto di questo musicista, e l’occasione formale mi venne offerta da Luca Cerchiari che conoscendo la mia passione sia per Paul Bley sia per la scrittura – all’epoca curava una collana per la casa editrice L’Epos di Palermo – un bel giorno mi telefonò e mi propose di scrivere qualcosa per la sua casa editrice. A quel tempo avevo ordinato una specie di autobiografia scritta da Paul Bley insieme a David Lee, un critico di jazz canadese, in una libreria canadese a Parigi. Il libro mi arrivò dopo tre mesi, un tempo così lungo che mi ero quasi dimenticato di averlo ordinato. Lessi il libro e proposi a Luca Cerchiari di tradurlo in italiano, ma Luca mi rispose di provare semplicemente a scrivere qualcosa su Paul Bley. Così è nato il libro. Avevo conosciuto Paul Bley diversi anni prima a Milano, verso la fine degli anni ottanta. Ma questa si potrebbe considerare come la parte meno importante di tutta la storia perché scendendo nei dettagli, tra me e lui, oltre all’ostacolo della lingua – non è che conoscessi l’inglese particolarmente bene – c’era anche il suo modo di rapportarsi e di comunicare con le persone. Mi raccontava Steve Swallow, che lo conosceva molto bene, che quando si trovava a suo agio poteva essere molto “fluente” e soprattutto “eloquente”, mi ricordo molto bene questa parola. Ma con me non lo è mai stato particolarmente. Quando gli rivolgevo delle domande aveva come l’abitudine di fare delle battute che avevano qualcosa di zen, come se si esprimesse mediante aforismi. Sicuramente mi guardava con molta simpatia e affetto, con un certo paternalismo che personalmente, da lui, accettavo ben volentieri. Alla fine ho avuto la possibilità di invitarlo all’Auditorium di Milano per tenere un concerto durante una rassegna di jazz che organizzai nel 2004. In quella circostanza presentai il mio libro su Paul Bley che era appena uscito, lo presentai sul palco e Bley era accanto a me ma non disse niente. Il concerto non fu uno dei suoi migliori – probabilmente era stanco o incominciava ad essere stanco, anche se restava pur sempre un uomo avventuroso e soprattutto affascinante. Dopo aver suonato, insieme a mia moglie lo accompagnai all’hotel Hilton di Milano, gli feci da taxista e ci mettemmo a parlare. Quella fu l’ultima volta. In seguito ho avuto contatti con la moglie e le figlie, ma non con lui. Solo dopo ho saputo che era stato a Roma per un concerto con un pianista americano di nome Greg Burk, – grande ammiratore di Paul Bley – che avevano parlato del mio libro e che ironicamente Bley aveva detto: “Mi piacerebbe sapere che cosa ha scritto Cappelletti su di me!”, così ha proposto a Greg Burk di tradurlo. Assistito da alcuni traduttori, Greg ha tradotto il libro che è uno dei pochissimi libri scritti da un musicista italiano ad essere stato tradotto in lingua inglese. Ecco il motivo per cui questo libro ha una sua storia tutta particolare ed è apprezzato anche da persone che provengono da mondi completamente diversi, come nel tuo caso che provieni dalla pedagogia.
Sono rimasto affascinato dal tuo libro sia per come riporta la vita e il mestiere di una artista unico nel suo genere come Paul Bley, sia per ciò che scrivi sulla musica, anche in una direzione che potrei definire “pedagogica”. Ad esempio a pagina diciassette leggo una cosa che mi ha molto colpito:
“Ma non esiste, se non nei Conservatori e nelle accademie più sclerotizzate, o, viceversa, nel balbettio degli incapaci, una musica irrigidita in un sistema o totalmente libera da esso”[1].
Questa frase mi ha colpito perché tutto il mio lavoro sulla pedagogia musicale è incentrato proprio nel provare a rimuovere questa rigidità, in modo da riconferire corporeità, soggettività e, nei casi più lungimiranti, un certo senso del desiderio di fare musica. E poi continua:
“La storia della musica è la storia della ribellione alle regole nel loro rispetto, del loro sovvertimento dall’interno”[2].
Sono parole che si incontrano raramente, soprattutto perché dette in modo così diretto, con schiettezza. Sicuramente c’è un fondo di verità in ciò che affermi perché sono circa venti anni che insegno musica e trovo sia nei colleghi, sia negli studenti un’estraneità di fondo al linguaggio musicale nonostante la pratica continua e una certa passione per la musica.
Ti ringrazio veramente, le tue parole mi fanno un piacere enorme anche perché ho visto le tue ricerche e ho letto che cosa scrivi, e quindi capisco che abbiamo in comune certi argomenti. Questa faccenda dell’irrigidimento vale per qualsiasi musica ma in particolare per il jazz, ed è una cosa scandalosa. Da docente di musica jazz, per quasi quarant’anni ormai, dato che ho iniziato ad insegnare quando ero molto giovane, ho avuto modo di verificare gli effetti negativi di questo approccio al jazz che in fondo è una musica viva, che vive nel momento in cui la si crea, o per lo meno così dovrebbe essere: si tratta di una realtà particolarmente controproducente da tutti i punti di vista. Purtroppo, in questo senso, i vari metodi che hanno scritto gli americani, in modo particolare quelli in uso alla Berklee School di Boston, hanno fatto dei bei disastri.
Quindi questo approccio errato non riguarda unicamente noi europei?
No, no, purtroppo no; noi italiani, in particolare, siamo molto provinciali. Il metodo è una realtà che dà molta sicurezza, sia all’allievo, perché è la prima volta che si confronta con il jazz, sia al docente. L’allievo che per la prima volta si confronta con l’improvvisazione ne ha ovviamente paura, e quindi avere qualcuno che offre delle indicazioni e spiega cosa fare, indicandoti non solo la strategia secondo cui muoverti ma esattamente cosa devi fare, tutto questo regala una grande tranquillità, quella tranquillità che poi alla fine può compromettere la spontaneità dell’improvvisazione. In questo senso mi sembra tutto molto pericoloso, perché certamente la sicurezza aiuta a superare quella paura del salto nel vuoto che per sua natura c’è nell’improvvisazione.
C’è da precisare comunque che il jazz è un codice in movimento e che esiste a tutti gli effetti un codice jazzistico: non è che io rifiuti a priori questo codice, non sono per l’anarchia totale, non rifiuto a priori qualsiasi regola o legge. Se un allievo mi chiede di voler suonare secondo lo stile di un certo musicista, cerco con la mia forma mentis – che mi deriva anche dagli studi universitari in filosofia – di indicare quali siano gli elementi di questo codice. Però poi, al momento di suonare, queste cose vanno un po’ dimenticate. Nella mia prospettiva di docente è importante dare un’indicazione di tipo operativo oppure pragmatico, anziché limitarsi ad indicare leggi, note, regole e codici. Personalmente cerco di individuare come e quale sia la modalità per arrivare a suonare in un certo modo, e questo è un processo completamente diverso, perché se propongo soltanto la regola l’allievo cercherà sicuramente di ricopiare e a quel punto tutto va a farsi benedire. Molto diverso è invece cercare di indicare una strategia. In un libro che ho scritto, non ricordo se l’ultimo, ho messo una parola che uso spesso ed è quella che riguarda i “trucchi”, una parola volutamente dissacrante proprio perché alle volte anche nei confronti dell’improvvisazione c’è questo approccio definibile come misticheggiante che porta la gente che ti ascolta e che ti segue a chiedere: “Ma come fate?”, o “Ma come si fa?”. Certi colleghi ad esempio, specialmente quelli che provengono dall’ambito classico, se ne escono con domande del tipo: “Ma come fate voi jazzisti? Ma è un miracolo!”. Non c’è quasi niente di miracoloso, anche se alle volte qualcosa di miracoloso si materializza, ma di questo elemento miracoloso, personalmente preferisco non parlare, proprio perché si tratta di una cosa miracolosa e per questo è meglio lasciarla stare. Diciamo che la cosa da dire è che c’è tutto un processo di apprendimento ed è questo l’elemento importante.
Ho letto riguardo ai tuoi testi, dalle sintesi agli articoli che trovo sul tuo sito, qualcosa che mi permette di capire la necessità di lasciare spazio, libertà di movimento allo studente, contro una certa pedagogia padronale. Sono verità che vanno benissimo, ed è vero anche che la responsabilità dell’insegnante non è solo in negativo ma di offrire allo studente delle vie, delle strategie che possano risultare stimolanti.
Concordo in pieno. L’essere maestro è una “forma di paternità”, ha scritto un importante musicista di cui non ricordo il nome, per cui la responsabilità, se l’insegnamento, la trasmissione del sapere li si vedono in questa direzione, inevitabilmente diventa una grande responsabilità. Non si tratta quindi di insegnare soltanto regole o grammatica. Il linguaggio musicale lo considero inevitabilmente nella direzione di Ludwig Wittgenstein, ovvero come gioco linguistico, un linguaggio musicale, una cosa viva e in trasformazione, e anche i partecipanti a questo gioco linguistico devono per forza di cose esser tali.
Certamente è un presupposto fondamentale, perché l’immobilità poi ti mette fuori gioco e ti toglie da una dimensione creativa.
Tornando al tuo libro su Paul Bley, come vedeva lui l’insegnamento della musica? Ti chiedo questo perché ci sono alcune pagine nel libro che sono veramente interessanti, pagine meravigliose, ad esempio quelle del paragrafo “Socrate”.
Paul Bley, nelle dichiarazioni che ha reso in quella specie di autobiografia, (la definisco “specie” perché è stata scritta in seguito ad un’intervista) ha lasciato tracce del suo pensiero pedagogico, ma sono cose che diceva in senso molto provocatorio, per cui è necessario, dal mio punto di vista, fare la tara a certe sue affermazioni. Lui amava la provocazione e la battuta ad effetto e per questo è necessario interpretare certe sue affermazioni. C’è un aneddoto, un racconto in questo libro che può dare l’idea di quale sia la sua filosofia dell’insegnamento. Un giorno si presentò una pianista giapponese con la richiesta di voler imparare a suonare da Paul Bley. Le rispose dicendo che se voleva poteva andare da lui ad imparare per la durata di circa tre, quattro anni, l’altra possibilità era di andare il giorno seguente in uno studio di registrazione e provare a suonare insieme. Alla fine ne è venuto fuori un disco. Non che sia sempre possibile fare un’operazione di questo genere con gli allievi, però sicuramente Paul rivendicava il “gettare” l’allievo, come si dice quando qualcuno non sa nuotare e ha la necessità di imparare a nuotare, gettarlo letteralmente nell’acqua, così come, ad esempio, chiariva che non si può insegnare ad improvvisare se non improvvisando.
Mi è sembrato quindi di poter intuire che per Paul Bley – ma anche sulla base della mia esperienza personale perché è una cosa che applico anche nel mio insegnamento – bisogna invitare l’allievo ad improvvisare, a suonare quello che gli piace, quello che sente e gli viene spontaneo, senza mai frapporsi. Occorre invitarlo semplicemente a suonare. Una volta suonato, allora l’intervento del maestro può diventare utile, utile ad esempio fare delle osservazioni su ciò che ha realizzato, ma sempre seguendo quella che è la sua pulsione, senza imporgli un modo di suonare astrattamente pensato come giusto. Tutto questo anche per il fatto che il jazz offre infinite prospettive e possibilità di approccio all’improvvisazione. Una volta ascoltato l’allievo ed averlo invitato ad approfondire e ad approfondirsi, gli possiamo offrire quelle indicazioni necessarie per andare a incontrare il suo modo di suonare, per potenziarlo ma solo se si è compresa la sua direzione. Possiamo consigliargli di evitare quel passaggio o quella scala, ma sempre in relazione al suo vissuto, alle sue necessità. Chiaramente questo può avvenire nel caso di qualcuno che sia già in grado di buttarsi e di far sentire delle cose, ma se abbiamo di fronte a noi un allievo bloccato, come si dice, allora andiamo avanti con altre modalità perché si è letta una certa impossibilità ad esprimersi, a tirare fuori quello che ha dentro. Negli anni ho inventato delle strategie per capire cosa abbia da dire un certo allievo. Alle volte, certi musicisti basta invitarli a lavorare su una semplice scala pentatonica per tirare fuori qualcosa, questo può bastare. Sono consapevole però che non a tutti può piacere la semplice scala pentatonica, quindi è necessario dare una direzione, in qualche modo, altrimenti diventa difficile progredire. Facciamo un esempio a partire dallo swing, che dal mio punto di vista è una delle cose più innaturali per quasi tutti i musicisti, salvo qualche rara eccezione cui viene naturale: suonare con swing per qualche studente è quasi impossibile, inarrivabile. Non è detto che suonare con swing significhi suonare terzinato, alla Peterson, perchè si può suonare con swing in altri modi. Se ascoltiamo ad esempio Chick Corea, questi ha un approccio latino e si fa accompagnare da musicisti straordinari come Roy Haynes che suonano con swing mentre lui suona su altre strade che non hanno niente a che fare con lo swing classico. Allora, dare degli esempi per far capire che lo swing non è quella roba terribile come si crede comunemente, oppure dire che lo swing non è il “ballo dell’orso”, sono tutti strumenti per indicare allo studente in che direzione muoversi, e in tutto questo l’insegnante ha il ruolo positivo di accompagnare l’allievo nel tirare fuori quello che ha, se lo ha.
Sacrosanto, meraviglioso, da brividi. Il mio problema è che lavoro ad un livello veramente basso, parlo di scuole di stato o scuole di provincia, dove veramente di rado capita di ascoltare parole come le tue in cui si presta attenzione e sensibilità alla natura dell’allievo cercando di lavorare e di far crescere e maturare il suo potenziale. Troppo spesso mi trovo di fronte a professionisti scalcinati che si inventano pedagogie che non esistono o che semplicemente rigettano sull’allievo quel medesimo trattamento che hanno avuto in sorte a loro volta dai propri insegnanti. Insomma, una pedagogia molto poco ragionata. Tornando a Paul Bley, quando dici che certe sue battute erano dette più che altro per realizzare un effetto, si può pensare a cose come quel celebre aforisma in cui Paul Bley dice: “Le lezioni tolgono più di quello che danno”?
Sì, Bley aveva un approccio molto negativo nei confronti della docenza.
Comunemente, le persone si affidano totalmente all’insegnante talvolta, senza nessun calcolo, senza avere il timore di perdere qualcosa di sé, mentre il pericolo di perdere elementi importanti della propria musicalità c’è eccome.
È vero, questo è un punto molto sottovalutato. Noto sempre che c’è l’attesa che arrivi la nozione bella e pronta che ci possa far diventare bravi. Insegnando al Conservatorio mi capita di fare delle lezioni puramente teoriche in cui gli allievi entrano in aula, prendono appunti e poi non so cosa rimane di quello che dico. Questo perché non amo separare la teoria dalla pratica e lo trovo assurdo, specialmente per quanto riguarda il jazz. Anche nelle lezioni ad esempio di Tecniche compositive, cerco di dare gli strumenti per esprimersi e non semplicemente per imparare la teoria. Noto comunque che c’è questa attesa quasi messianica nei confronti del docente che è quello che sa e conosce cosa è meglio per noi. Può darsi che sia anche un modo per ottenere sicurezza, perché davanti a noi c’è un insegnante che si assume la responsabilità dell’insegnamento, e alle volte può essere estremamente gratificante per il docente, ma non è una cosa corretta, perché la vera gratificazione è quando riesci a mettere in movimento uno studente, a renderlo musicale perché hai fatto leva sulla sua musicalità, in particolare nel caso del musicista di jazz, perché non c’è soltanto l’interpretazione dello spartito ma anche la creazione di musica in tempo reale.
Per quanto mi riguarda, ad esempio, il mio rapporto con Paul Bley è stato un’occasione per realizzare una riflessione su me stesso nel senso che questo grande amore che ho nutrito e che nutro tutt’ora per questo maestro del jazz, è stato uno strumento importante e necessario per fare chiarezza dentro di me, per capire cosa volevo fare, che tipo di musica volevo suonare. Ecco, i maestri servono soprattutto a questo.
Qui si raggiunge un livello importante che è raro da trovare, soprattutto perché lo si realizza sempre in due, anche se il maestro ha in qualche modo la responsabilità di porsi in quel luogo dove avverte una necessità da parte dello studente di essere trovato. Insomma, non si tratta solo di insegnamento, l’alchimia è cosa ben più complessa…
Ma certo, perché si chiariscono molte cose, soprattutto quelle che non sono scritte da nessuna parte.
Ma è vero che Paul Bley aveva questa specie di riluttanza nei confronti della musica scritta?
Questo rimane un punto abbastanza misterioso nella storia di Paul Bley proprio perché è vero. Quando gli chiesi di mandarmi qualcosa di scritto, lui e la moglie mi presero un po’ in giro. Bley aveva studiato alla Juilliard School e quindi la musica la conosceva eccome, è evidente. È un po’ il solito discorso che si fa con Monk quando ci domandiamo se sapesse suonare il pianoforte. Ma certo che lo suonava, ci sono le prove, anche se la sua nipotina lo criticava perché suonava Chopin troppo veloce. Quindi, tornando al discorso, Bley la musica la conosceva, ma aveva questo approccio appunto “provocatorio”, per cui rifiutava la scrittura. Sembra che in effetti non abbia mai scritto materialmente. Ci sono i brani a sua firma, però, dal mio punto di vista, sono cose che ha dichiarato a causa dei diritti di autore, ma secondo me non ha mai impugnato la matita. Questo naturalmente a partire da una certa età, sicuramente quando era giovane scriveva.
E questo, secondo te, per quale motivo? Per una sorta di ribellione alla grammatica musicale, per una sorta di libertà o cosa?
No, no, proprio per il fatto che la scrittura risulta pericolosa. Per un jazzista che fa delle improvvisazioni autentiche, la scrittura rappresenta un limite. Prima parlavamo di irrigidimento, no? Questa è un’esperienza che posso testimoniare anche in prima persona: quando vedo una partitura, o semplicemente un tema scritto troppo bene al punto che non cambierei una sola nota, un tema scritto così bene come Paul Bley diceva a proposito di certi temi scritti da sua moglie Carla, temi che avevano questo aspetto “inevitabile”, diceva proprio “inevitable”. Questa inevitabilità risulta estremamente bloccante nell’improvvisazione, nel senso che non riesci a compiere quella operazione di modificazione, di trasformazione del dato che poi rappresenta l’essenza del jazz. Qualcuno potrebbe dire: ma l’improvvisazione non è la modificazione del tema, perché l’improvvisazione è sulla struttura armonica del tema e del brano. No, non è vero! L’improvvisazione deve essere già … modificazione del tema. Specifichiamo: non c’è il tema e poi l’improvvisazione. I due momenti devono essere integrati; questo, naturalmente, è il mio punto di vista, sarebbe stato molto interessante chiederlo direttamente a Paul Bley, ma purtroppo non è più possibile. Però mi posso permettere di dire che lo conoscevo così bene dal punto di vista del pensiero musicale che la sua concezione dell’improvvisazione andava sicuramente in questa direzione. La scrittura cioè può risultare in qualche modo “bloccante”. Una dimostrazione di quanto sto dicendo si può avere quando realizzo un disco riuscito bene, veramente bene e che al suo interno presenta improvvisazioni così perfette e belle che quando suono nuovamente il pezzo cerco di imitarle: ne nasce inevitabilmente un disastro. Un disastro. Questo perché utilizzo come riferimento qualcosa al di fuori di quello che sto facendo in quel momento e che non ha niente a che fare con il momento in cui sto improvvisando.
È come se fosse un altro lavoro!
Esattamente, come se fosse un altro lavoro. Anche se l’ho fatto io, mi è totalmente estraneo.
Certo! Perfetto!
La scrittura può risultarti estranea anche se l’hai scritta tu stesso. Dico questo anche se a me piace scrivere. Personalmente ho inventato un neologismo, quello della “neg-scrittura”, cioè una scrittura che si autonega, cioè uno scrivere delle cose che sono fatte per essere trasformate. Un tipo di scrittura non rigida ma elastica, aperta, che in qualche modo possa risultare addirittura stimolante. Allora a quel punto non è più un ostacolo, ma diventa un elemento di stimolo. Perciò la mia personale ricerca in questi anni mi ha condotto a non scrivere cose perfette, anche se non si tratta di “scrittura aperta”, un discorso di codici aperti o chiusi alla Umberto Eco, ma un tipo di scrittura che sia anche abbastanza chiusa, una scrittura che appunto si autonega.
E quindi, tornando al tuo libro, mi puoi chiarire che cosa è “La logica del caso”, che poi conduce alla musica del caso, qualcosa che trovo a pagina 28 del tuo libro su Paul Bley nel paragrafo intitolato “La musica del caso”.
Mi piaceva giocare con il titolo di un romanzo di Paul Auster che avevo appena letto.
Il caso è un concetto che non è casuale. Il caso è come l’improvvisazione. Personalmente parto da un insegnamento, quello di Jacques Lacan, che chiarisce che il caso non esiste, per cui questa cosa mi intriga non poco…
Certo, certo, ho avuto amici filosofi che mi hanno contestato questa cosa e non pretendevo di infilarmi in una discussione sul dato se il caso esista oppure no. In realtà mi sforzo di partire dal mio vissuto, dalla mia esperienza di musicista e quindi alle volte, quando uso questi concetti, posso sembrare poco rigoroso per il fatto che cerco di esprimere più che posso il mio vissuto. Però quello che volevo chiarire è qualcosa di molto forte.
Trovo bellissimo quando scrivi:
“Quando un creatore è lasciato a se stesso tende ad assimilare gli eventi ad una prospettiva o idea di fondo, col risultato di renderli noiosi e prevedibili. Paul Bley è differente. Vuole che la musica sorprenda fin quasi alla fine, quando gli eventi suggeriranno finalmente un’idea”[3].
Cioè musica come evento, come casualità, qualcosa che come si dice cade tra capo e collo.
Sì, l’idea è questa. Alle volte ho la sensazione che Bley butti le mani a caso. Buttare le mani a caso non vuol dire che non abbia senso, ma significa che in quel momento ha la necessità di andare avanti per una strada che gli viene perché è determinato ad agire in questo modo. Capita anche a me di buttare le mani con una certa apertura alare tra le dita, quella che io chiamo “versione a papera”, qualcosa che uso come metafora per illustrare la musica di Debussy, cioè la musica impressionista, il che può significare: se metti le mani “a papera” realizzi un effetto Debussy. Si tratta di accordi quartali, con posizioni molto aperte, per un suono molto liquido. Quindi Bley butta le mani, e questo buttare le mani è qualcosa di straordinariamente istintivo, o se vogliamo più che istintivo, di spontaneo, qualcosa di affascinante, tremendamente affascinante. La cosa che mi ha colpito di Paul Bley è questa sua incredibile “naturalezza” che non si trova secondo me, forse, in nessun altro pianista della storia del jazz. Il mio è uno sforzo di inseguire, purtroppo senza mai arrivarci, questo stesso effetto di naturalezza, quello che in una recente edizione degli scritti del pittore El Greco viene definito “il miracolo della naturalezza”. E come si ottiene questo effetto? Lo si può ottenere anche affidandosi al caso, lasciando che gli elementi accadano. Nel momento in cui scopro di aver fatto certe cose, a quel punto subentra un minimo controllo mentale, se non razionale, nel senso che riesco a trarre delle conclusioni in relazione a ciò che ho suonato. Questa è una cosa estremamente interessante. E oggi, non scriverei più nel mio libro: “Ho visto delle strane e misteriose simmetrie”, perchè in queste strane e misteriose simmetrie che vengono fuori dalla casualità degli eventi che accadono possiamo trovare qualcosa in più, di speciale e di particolare. Penso che Bley mi avrebbe preso in giro per una cosa del genere perché è tipico dell’europeo colto e intriso di cultura occidentale che si vanta, anche se non esplicitamente, di essere un intellettuale, un filosofo che ci mette del suo. Questo Bley lo rifiutava perché giocava a fare il non intellettuale, anche se poi lo era eccome! Insomma, è bene chiarire che la sua era un’operazione molto strana, perché quando si parla di caso non è che per forza di cose si debba andare alla ricerca di qualcosa che sta “sotto”, qualcosa che c’è e che si tenta di scoprire, ma al contrario è il fatto stesso che questi eventi accadono come se disegnassero una certa logica. Si tratta di una metafora. Comunque utilizzare un ossimoro del genere come sottotitolo di un libro è qualcosa che sicuramente non è dispiaciuto a Paul Bley, anche se non me lo ha mai detto, essendo la sua musica e non solo un continuo ossimoro. Amava stupire con i suoi ossimori nelle conversazioni e naturalmente soprattutto nella musica, che risulta davvero una sintesi di opposti, lirismo e anti-lirismo, tempo metronomico e tempo libero, tonalità e atonalità. Mi ricordo che una delle ultime frasi che mi ha detto quella sera al bar dell’Hotel Hilton di Milano è stato: “Don’t forget that music is surprise, surprise, surprise”. Sorpresa, sorpresa, sorpresa. Bley era uno che tutto quello che diceva, anche se poco, aveva molto ma molto senso. Penso quindi che se insisteva così tanto nel sottolineare l’elemento di sorpresa nella musica – ci rifletto ancora adesso nonostante siano passati dodici anni – questo sicuramente aveva per lui un senso profondo.
Ma quale era la dote di Paul Bley che spiccava subito ad occhio?
Certamente l’ironia, un’ironia molto bonaria, distaccata talvolta sprezzante. Bley certamente aveva una componente snob, vagamente blasè come persona, e questa era una cosa che a me personalmente non ha mai dato fastidio, perché penso, e ne sono sicuro, che corrispondesse a una consapevolezza profonda del proprio valore. Ma anche nei miei confronti avvertivo una certa ironia vagamente paterna, affettuosa. Questa è la sensazione che ho avuto e in genere è difficile che mi sbagli in queste cose.
Si rimane affascinati da queste parole, sia per ciò che hai scritto nel libro sia per quello che mi hai raccontato di Paul Bley, ma anche per la tensione pedagogica, per il lavoro di ricerca su come trasmettere il sapere musicale, una cosa che si riscontra raramente devo dire. Il mio punto di partenza è quello di togliere il guinzaglio alla formazione musicale e non di metterlo, e questo perché il mio taglio educativo si rivolge all’infanzia e soprattutto all’adolescenza a quelle che sono le prime stagioni di vita del musicista. Per questo sono contrario ad una modalità di proporre o imporre una musica che impaurisca, che metta soggezione, che limiti fino all’inibizione.
Condivido in pieno e per me è un grande piacere scoprire quante cose abbiamo in comune. Poi devo dirti che ho una analoga passione per la didattica, insegnando ormai da tanti anni, però non ho mai avuto modo di parlarne con qualcuno. Tutte le conversazioni su questo argomento me ne confermano l’importanza al punto che giungo alla conclusione che se ne parla veramente troppo poco. Con gli allievi non so fino a che punto può essere consigliabile parlarne perché loro sono la carne viva dell’esperimento. Mi è capitato di parlarne diverso tempo fa con un ex allievo perché quando la pratica dell’insegnamento ha un esito positivo in un certo senso si diventa amici, no? Ma non ho mai affrontato questo argomento con un collega, un docente. Anche per me è una conversazione importante questa, e spero che in futuro ci possa essere occasione di parlarne in modo più approfondito.
Un’ultima domanda: che ruolo ha avuto la filosofia nella tua carriera di musicista?
Questa cosa della filosofia viene considerata come un ambito a sè, mentre personalmente la percepisco come parte costante del mio lavoro non solo come docente di filosofia (nei miei primi anni) e di musica ma come musicista. Ho infatti insegnato filosofia per diversi anni ma poi ho mollato per la musica. In fondo, la cosa del jazzista filosofo che può sembrare una cosa un po’ così, una boutade, effettivamente ha un suo senso. Non è un caso che mi trovi ad essere sia filosofo sia musicista. Non dico che sia la stessa cosa ma quasi, nel senso che anche quando suono e cerco di dimenticare tutto quello che penso e di lasciarmi andare, anche questa è filosofia insomma, perché probabilmente se non fossi uno molto portato alla riflessione non mi interesserebbe così tanto questo “lasciarsi andare”. Gli opposti si attraggano anche all’interno di una persona.
È il platonico per eccellenza, quindi: musica e filosofia!
Certo, ma poi alla fine c’è questo sano pragmatismo degli americani di cui Paul Bley, anche se di origine canadese, era un interprete eccellente, perché lui era uno di quelli che ti guardava come se ti volesse dire: “Beh, andiamo ai fatti!”, uno che alla fine era anche un po’ brutale se non avesse avuto quel suo sguardo dolcissimo. In due battute ti racconto che un anno, durante i primi anni della nostra amicizia, gli avevo dato una registrazione che avevo fatto con una mia amica cantante e altri musicisti, una delle mie prime esperienze di improvvisazione totale. A quel tempo, negli anni ’80, si andava avanti con le cassette audio e Paul prese questa cassetta e la portò con sé. Quando ci siamo ritrovati dopo qualche mese in occasione di un suo concerto con Charlie Haden, dopo il concerto ci siamo salutati e gli chiesi se avesse ascoltato quella registrazione, e lui mi rispose: “Yes, yes, but now we must talk about business!”. Cioè voleva produrmi quel disco, ma purtroppo quel disco era già uscito. Non avrei mai pensato che Paul Bley volesse produrmi un disco, e questa era la sua concretezza, come a dire: “poche balle, parliamo di affari!”.
Quindi vi siete frequentati per tanti anni?
Cappelletti: eh sì, perché ci siamo conosciuti nell’88. Solo che i primi anni, quando veniva a registrare qui a Milano, andavo spesso in studio a trovarlo. Mi invitava e assistevo tutto il giorno alle registrazioni; poi ci siamo persi di vista per un certo periodo di tempo e ci siamo come ritrovati in occasione dei suoi concerti in Italia. Alla fine, l’ultimo incontro c’è stato quando ho avuto modo di invitarlo nel 2004. Una frequentazione certamente durata molto nel tempo, ma sempre un po’ casuale, perché non c’è mai stata una frequentazione per diversi giorni di seguito, non l’ho mai invitato a casa mia anche se ne avevo il desiderio, non c’è mai stata l’occasione giusta. Devo anche dire una cosa, che per me è un maestro così importante che la sua importanza prescinde dal semplice fatto di averlo frequentato tanto o poco. Mi confronto con la sua musica da quasi quarant’anni, con il suo modo di essere e di parlare, e anche se molti mi dicono che avrei potuto andare a trovarlo non ne sentivo la necessità nonostante mi avesse lasciato l’indirizzo, perché conta altro in un rapporto del genere, così profondo e intenso. Sono contento che prima di morire abbia letto il mio libro, ecco…
Ma di che cosa è morto?
Non lo so, non ho voluto approfondire. La mattina in cui è scomparso mi ha scritto la figlia Angelica, per email. Mai io sapevo che già da qualche anno non poteva più camminare e non ho voluto approfondire, anche perché gli avevo scritto per ben due volte e non avevo ricevuto alcuna risposta. Due anni prima che morisse, la figlia mi aveva scritto in occasione di una festa in suo onore, mi chiese se avessi voluto scrivere una frase, due righe. Comunque in quegli anni era ancora in grado di capire. Qualcuno mi ha parlato di Alzheimer, ma non lo so. Molti non riuscivano più a parlargli da anni. Insomma, non ho voluto approfondire.
Sembra la classica uscita di scena di un grande musicista che sente di non avere più quelle importanti facoltà che aveva un tempo…
Sì, non riusciva più a suonare… credo che l’ultima esibizione importante l’abbia fatta nel 2008, comunque non mi risultano concerti dopo quella data. Non saprei dire di più, così come non ho scritto di più sul libro su di lui che è carente, per certi aspetti, di informazioni biografiche (nonostante abbia scritto il libro quando Pau Bley era in vita, sano e suonava ancora). Anche quando il libro è stato tradotto nel 2010, e certi punti sono stati ampliati, non ho inserito parti biografiche, perché non è un libro che si propone di esaurire l’argomento sul piano dell’informazione, non so se mi spiego… infatti qualcuno mi ha contestato questo dato dicendomi che potevo essere più preciso, più accurato. Il senso dell’operazione era un altro, era un approfondimento della poetica, e anche il modo in cui il libro è organizzato va in questa direzione. Questo è il motivo per cui molti lettori lo hanno amato, come te ad esempio, mentre altri più pignoli hanno iniziato invece a dire che non avevo citato quel disco ecc.
No… è bello così, non è un libro di chiusura, ma apre l’opera ad un altro piano di comprensione ….
Si può dire così, certo.
Per certi aspetti è più un manuale per un invito all’incontro della musica di Bley. Tutti i pignoli, come hai sottolineato tu, pensano sempre alla biografia o al saggio accademico, mai a qualcosa di diverso che si proponga altri punti d’arrivo o che parta da idee diverse.
Certo, perché i libri che vengono scritti sui musicisti, in genere hanno un carattere differente. Ma non tutti i libri devono per forza di cose essere uguali.
Note
[1] A. Cappelletti, Paul Bley. La logica del caso, L’Epos, Palermo 2004, p.17.
[2] A. Cappelletti, Paul Bley. La logica del caso, L’Epos, Palermo 2004, p.17.
[3] A. Cappelletti, Paul Bley. La logica del caso, L’Epos, Palermo 2004, p.28.
* * *
Intervista realizzata l’8 settembre 2017
Il Centro Sperimentale Pedagogico Tyche ricorda che tutti gli articoli presenti all’interno di questo sito possono essere liberamente consultabili e scaricabili. In caso di utilizzo del nostro materiale sarebbe onesto, nonché eticamente corretto, contattare gli autori e citare la fonte. Il Centro Sperimentale Pedagogico Tyche ringrazia e augura buona lettura.